Contenuto
Il Presbiterio e l’Abside
con l’Altare del Cristo Redentore ed il retrostante Coro
La ripresa fotografica sopra riprodotta dell’abside, simulando l’effetto stereoscopico, intende dare una visione d’insieme avvolgente e più completa.
Per una accurata descrizione ed analisi storica del presbiterio si riporta quanto scrive Filomena Lorizzo nel testo citato:
Sul presbiterio, sopraelevato di un gradino, è situato un altare, retto da una tozza colonna, poggiato a un pilastro in muratura che sostiene la volta anulare dell’abside.Sul pilastro è affrescato un Cristo benedicente, che regge con la mano sinistra un libro, sul quale si legge l’espressione evangelica “Lux Ego sum mundi”.
Si tratta di una committenza di fine Quattrocento, quando, molto probabilmente, si decise di affrescare le pareti interne della Cripta.Lungo il perimetro dell’abside gira un gradino, ricostruito negli anni trenta e interpretato come sedile per i presbiteri durante le cerimonie liturgiche.Nella parete sud del presbiterio c’è un arcosolio murato e accanto è visibile una canaletta che confluisce, proseguendo lungo la pavimentazione, nel pozzo che si apre sotto l’altare.
Anche nel muro nord c’era una canaletta verticale, laddove successivamente è stata aperta una porta di accesso alla sacrestia; tuttavia rimane la traccia della canaletta orizzontale.
… … …[Nei lavori eseguiti nel Quattrocento] la volta anulare dell’abside, retta da un pilastro centrale, si addossa alle finestre a doppia ghiera, rendendole inutilizzabili; la finestra di sinistra risulta tranciata dal muro esterno del vano – sacrestia, edificato a nord – est dell’abside in questa fase dei lavori.
Sicuramente la copertura dell’abside e il vano antistante alla Cripta sono stati eseguiti quando si era deciso che l’abside e il coro diventassero un ambiente sotterraneo; dunque le feritoie e le finestre non servivano più, …
[tratto da "La Cattedrale di Andria", di Filomena Lorizzo, tip. S.Paolo, Andria, 2000, pp. 30-31, 57]
Nelle due foto di seguito proposte in primo piano emerge l’altare adiacente al pilastro centrale affrescato che divide l’abside,
sulla destra affiora
un arcosolio, dietro sul perimetro semicircolare è adagiata in muratura
una rifatta panchina del coro,
a sinistra un accesso arcuato immette in un ambiente di servizio,
sul pavimento è visibile la traccia scura della canaletta dell’acqua piovana che scarica in una cisterna
dall’imboccatura circolare.
Le notevoli differenze, sia della dimensione dei conci che del colore delle malte interstiziali,
nonché le numerose asimmetrie e incongruenze in vaste parti delle murature e delle volte,
evidenziano le modifiche apportate in diversi interventi nei secoli, eseguite non tanto
per un restauro conservativo dell’antico edificio quanto per ampliare e consolidare la Cattedrale superiore.
Un esempio di tali interventi deturpanti che hanno sacrificato l’abitabilità e l’estetica di questo ambiente sacro ridotto a cripta sono le finestre dell’abside, le quali, come indicato nel su citato testo della Lorizzo, nella parte alta si incuneano al di là delle rifatte opprimenti volte e murature quasi a voler comunque emergere in cerca di un raggio di sole; qui sotto si documentano in tre foto.



[le due finestre absidali viste dall'interno e quella di sinistra vista dall'esterno - foto di Sabino Di Tommaso - 2008]
A fianco dell’abside, sul lato sinistro del presbiterio, un arco di stile pre-romanico, che si differenzia da
quelli delle volte per la sua perfetta semicircolarità, conduce nell’adiacente sacrestia, il cui
pavimento è di molto più alto di quello della cripta e della sua abside,
sembra di livello pari alla vicina absidiola.
Si osservi che la soglia è giuntata e quindi originariamente più stretta, l’arco è sfasato a sinistra
rispetto alla parete e i conci superiori sono molto disomogenei, la
canaletta dell’acqua piovana già esistente nella parete (e visibile nel pavimento) è stata tranciata:
questo insieme di dati indicano che l’accesso originale fosse più stretto con arco ribassato e centrato nella vela della volta.
Che sia una modifica successiva è confermata sia dalla foto che mostra lo stesso
passaggio visto dalla parte opposta (dalla sacrstia), sia da una foto scattata nel 1903/4, prima di
alcuni
lavori eseguiti ad inizio Novecento.

-CD.jpg)
-CD.jpg)
[Il lato sinistro dell’abside nel 1903/4 (foto nel libro di R. D’Azzeo); l’attuale arco di passaggio e lo stesso passaggio visto dalla sacrestia - foto di Michele Monterisi - 2009]
Nell'intera aula dei fedeli ma soprattutto qui, nel piccolo presbiterio, le
fughe in pietra chiara dei muri perimetrali spingono lo sguardo a mirare il
fulcro dominante dell'insieme: il luogo del sacrificio, la mensa altare e,
incombente su di essa, a garanzia e sigillo di fede, l'affresco del Cristo
Redentore.
Al momento in cui la cripta nell'anno 1904 fu ripulita dalla sua funzione di ossario e
deposito di reperti scultorei l'altare si presentava così come mostrano
le foto del 1903/4; l'affresco del Cristo era nascosto dietro un arco -
contrafforte di sostegno e rinforzo della volta, struttura aggiunta probabilmente quando fu edificato il presbiterio
della chiesa superiore sovrastante la cripta.
Su detto rinforzo posto davanti all'affresco del Cristo e poggiante sull'altare l'Haseloff vide
resti di un dipinto di epoca evidentemente successiva raffigurante una Madonna in trono.
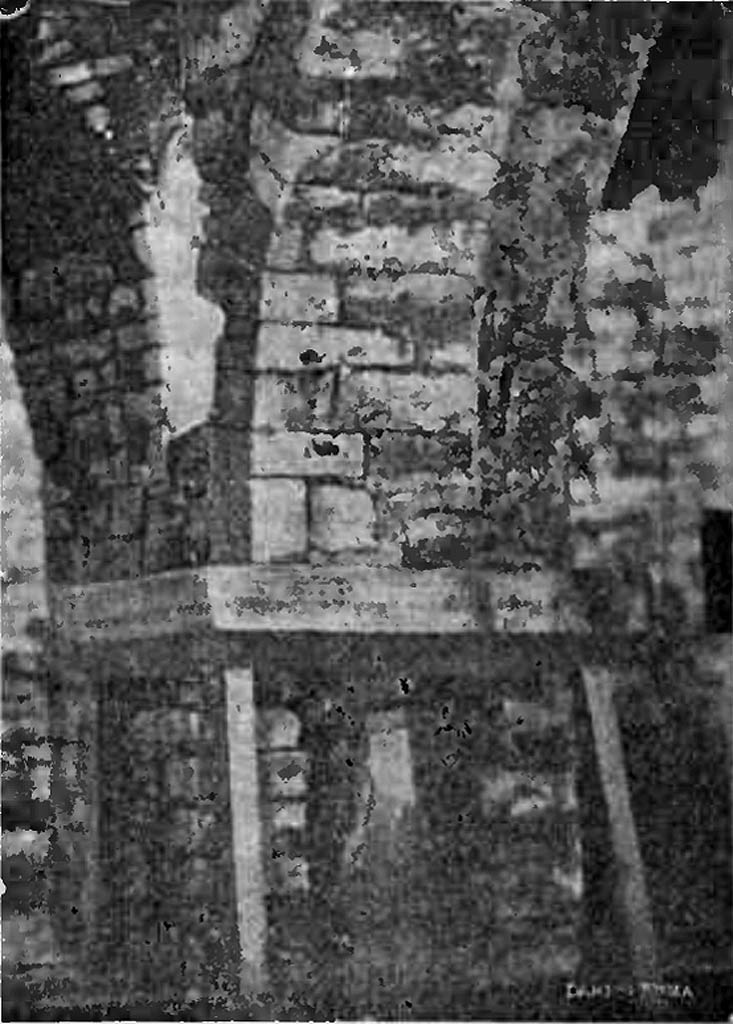
-CD.jpg)

[L’altare nel 1903/4 (foto dal libro di A. Haseloff); il pilastro con l’affresco e l’altare; il particolare delll’affresco del Cristo Redentore - foto Michele Monterisi,2009 e Sabino Di Tommaso, 2006]
L'arch. Haseloff, quando nel 1904-1905 studiò questa chiesa inferiore della cattedrale
e i reperti ivi trovati nel ripulirla, descrisse il presbiterio col pilastro e l'altare a
pag. 13 del suo “Die Kaiserinnengräber in Andria”.
Inoltre tra le varie ipotesi di collocazione dei reperti marmorei avanzò anche la possibilità che nel Duecento potessero essere stati
elementi di un baldacchino - ciborio eretto sull'altare di questa chiesa; di detta ipotesi ne parla
a
pag. 60 dello stesso lavoro (qui ambedue i brani tradotti).
… dietro il pilastro più recente in cui è integrato l’altare (Fig. 3) è stato scoperto un grande pezzo del dipinto originale ben conservato, chiaramente visibile mediante luce elettrica; si trova nello spazio tra il pilastro originale e il detto rinforzo più recente e raffigura un Cristo in piedi di cui sono perduti la testa e i piedi.
La figura risalta su uno sfondo blu e sotto una linea di demarcazione bianca su uno sfondo marrone. Cristo è vestito con una tunica bianca con sfumature azzurre, decorata con una striscia rossa sulla spalla destra e un bordo della manica, tra due orli neri bordati di bianco, una striscia gialla con quadretti marroni e punti bianchi. Sopra la tunica indossa il pallio marrone scuro, ravvivato da luci azzurre, ombre nere e punti bianchi. Cristo tiene la mano destra benedicente davanti al petto con il gesto greco: il pollice tocca la punta del mignolo. Nella mano sinistra tiene il libro aperto con l’iscrizione (frammentaria): “Lux ego sum mundi ñ it p” su fondo blu.Quando dopo la ristrutturazione della chiesa inferiore l’immagine di Cristo dietro al pilastro rinforzato scomparve e la maggior parte degli altri dipinti furono distrutti, fu eseguito un nuovo dipinto, la cui estensione è difficile da valutare poiché sono sopravvissuti solo resti molto minori.
L’immagine principale si trovava apparentemente di nuovo davanti al pilastro (rinforzato) dell’altare: almeno credo di vedere lì i resti di una Madonna in trono, che, significativamente, aveva preso il posto dell’immagine di Cristo. Sembra che siano stati conservati pezzi del mantello rosso che scorreva sopra la testa e le spalle, così come il trono decorato con viticci che fungeva da seggio di Maria. La base era blu con un bordo rosso.
Naturalmente, qui non si può andare oltre le ipotesi generali e il compito di determinare l’età di questi dipinti sembra del tutto ingrato. In ogni caso dimostrano che la chiesa inferiore continuò ad essere utilizzata per scopi ecclesiastici anche dopo la ristrutturazione, tanto che non si può parlare di distruzione o sepoltura da parte degli Angioini.… Il ciborio sarebbe stato a tre lati, con il retro liscio in qualche modo coperto. Si tratta di un fenomeno del tutto insolito che deve essere stato causato da alcune peculiarità strutturali. Ciò si potrebbe spiegare se il ciborio fosse stato collocato sopra l’altare della chiesa inferiore, che era addossato al pilastro dell’abside. Le dimensioni corrispondono a questo presupposto: abbiamo calcolato che la larghezza libera è di circa 1,40 m (con forma arrotondata); il piano dell’altare è largo 1,37 m e profondo 0,90; L’altezza delle colonne e la larghezza netta dell’arco sarebbero di circa 2,30 m, mentre per l’altezza totale sarebbero sufficienti circa 2,70 m, misura che corrisponderebbe all’altezza della chiesa inferiore. Poiché il pilastro è più stretto della tavola dell’altare, ciò spiegherebbe perché abbiamo anche sul retro capitelli quadrilateri e le cavità per gli ornamenti angolari. Sotto il baldacchino sarebbe stata visibile l’immagine di Cristo.
[traduzione del testo di Arthur Haseloff “Die Kaiserinnengräber in Andria - Ein beitrag zur apulischen kunstgeschichte unter Friedrich II”, Editore Loescher & C.°, Roma, 1905. p. 60.]
[il testo e le immagini della pagina sono di Sabino Di Tommaso (se non diversamente indicato)]

-CD.jpg)
-CD.jpg)